- Il 14 gennaio 2019 alle ore 4:47 pm
Nato a Prato dove vive e lavora, dopo aver conseguito il diploma all’Istituto d’Arte di Pistoia frequenta l’Accademia delle Belle Arti di Firenze, partecipa a TU35 (nel 2015) a cura del Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato e a numerose collettive e personali, tra le quali due collettive al Museo Casa Masaccio di San Giovanni Valdarno, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma (ILMONDOINFINE) e al Museo del ‘900 di Firenze.

Massimiliano Turco, Divenire, 2016
Inchiostro nero su carta o, come nel caso delle opere esposte alla Galleria Nazionale di Roma, su marmo di Carrara. Il tuo lavoro offre un’innovativa interpretazione della pittura segnica grazie all’evidenza plastica che il segno dona alla superficie marmorea. Come nasce quest’idea e il tuo rapporto con il marmo?
L’utilizzo dell’inchiostro nero corrisponde ad una certa idea di semplicità a cui mi viene naturale aderire. È un passaggio essenziale, al limite tra i materiali della pittura e la pratica del disegno. L’inchiostro trova la sua misura nel segno e il segno corrisponde al tempo di una scarica di energia, che si ripete, mai uguale. Questa contingenza non può verificarsi su un supporto qualsiasi, credo di aver avuto sempre una sorta di conflitto con l’idea di supporto inteso semplicemente come sussidio. Semmai il segnare, sotto forma di inseminazione, si manifesta presso mondi preesistenti, presso un piano che già con la sua superficie mi suggerisce la propria natura e la propria storia. Così nascono le Zographia, carta e inchiostro, con il ritrovamento di vecchi fogli di carta dimenticati fuori dal tempo di una vita. Così, come le opere di marmo e inchiostro, tipo Flusso e Rizoma, che trovano la loro genesi nello scarto momentaneo, frammenti di marmo avanzati, fuori dallo spazio di una misura stabilita razionalmente. Può essere che il mio lavoro suggerisca un’interpretazione innovativa della pittura segnica ma mi sembra anche un lavoro, in qualche modo, come dire, primitivo. Non penso mai che il mio lavoro sia un susseguirsi di progetti o la realizzazione di idee. Semmai mi pare di ritrovarmi naturalmente dentro una pratica necessaria fatta di rapporti. Ad esempio, quello con il marmo, penso sia dettato dalla misura di un territorio, dalle suggestioni di un ambiente, dalle visioni di mondi.

Massimiliano Turco, Rizoma (dettaglio), 2014
Il tuo atto si traduce in un linguaggio di segni minimi e ripetitivi, ma non identici, rigorosi e sequenziali. Che rapporto ha il segno con il (di)segno della natura?
Non disegno mai per ottenere un risultato precostituito. È vero che questa ripetizione dei segni, questa scarica di energia, che si ripete in una sequenza ritmica e, certe volte, quasi microscopica, come in Flusso, è sostenuta da un rigore, un rigore desiderante, una disciplina fisiologica, ma nel mio lavoro non c’è controllo, non esiste un controllo razionale o stilistico finalizzato a qualche soluzione formale o ad un preciso risultato estetico. Il processo, l’atto, si traduce in un linguaggio che, credo, prenda il sopravvento sulla mia individualità, così, le figure informi, più evidenti in un’opera come Rizoma, emergono senza una mia volontà. I segni non possono mai essere identici perché sono il risultato di diverse contingenze, di svariate combinazioni e di energie che si manifestano tra il divenire segno del gesto contemporaneamente all’incontro del segno stesso con il (di)segno della natura. Da qui il riferimento ad una suggestione Deleuziana che amo molto, quella della “doppia cattura”, del “blocco di divenire”, una sorta di incontro, cioè, tra segno e (di)segno della natura, che si ritrae a sé stesso, che abita il percorso di una “deterritorializzazione”.
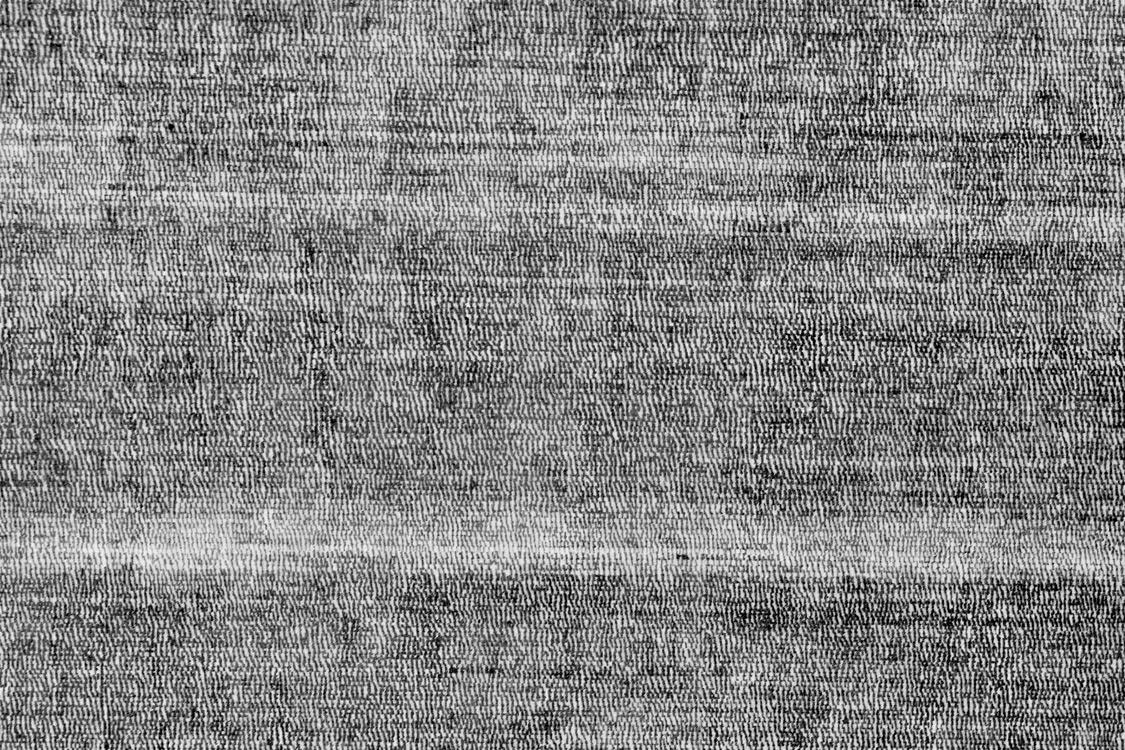
Massimiliano Turco, Flusso (dettaglio), 2013-2015
Ilmondoinfine: vivere tra le rovine. Questo il titolo della mostra della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea che ospiterà il tuo lavoro fino al 23 gennaio 2019. Come interpreti questo titolo? Le rovine come deriva o come approdo?
Credo che certi percorsi siano processi che vacillano entro certe questioni, per via della loro natura vagabonda, oppositiva e erotica. Le lunghe attese, gli spostamenti improvvisi, la ripetizione dei gesti, certi conflitti, sono solo alcuni tra i valori traducibili e fra altri, forse, intraducibili. Ad esempio, quello che faccio si costituisce in un gesto semplice, ma l’azione, che si protrae estenuante e che resiste, diviene come un’indagine sulla stanchezza. Eccolo un altro scarto (oltre agli scarti di marmo e di carte ritrovate) è quel vuoto che permette l’entrata, o l’uscita, di tutto ciò che accade nel mentre e che diventa parte integrante dell’opera. Si tratta, credo, di una sorta di involuzione generativa, rispetto anche ad una volontà individuale che lascia il posto al processo. Poi va detto che opere come Flusso e Rizoma continueranno a trasformarsi. Lo scarto si fa più evidente nella metamorfosi di un’opera che prosegue nel suo respiro generativo, orfana del rapporto egemone, illusorio, con l’artista. In Rizoma, come in Flusso, si verifica ancora quell’involuzione dell’opera che tende a raggiungere nuovi equilibri. Paiono emergere, invisibili, realtà che hanno già dentro sé traiettorie (finali?) a cui tendono evolversi. Ed è sempre l’ora di alterazioni e spostamenti, variazioni volumetriche, deterritorializzazioni indotte da ipotetici microrganismi e possibili muffe, espansioni termiche, disgregamenti, reazioni alla luce. Evidente, poi, in Rizoma il segno cromatico dell’ossidazione. Così, le opere continuano. Non vedono la fine di un fare pittorico inglobato in un processo in divenire di inchiostro in roccia e di roccia in inchiostro.
Ancora un esempio. Nell’opera Divenire, esposta sempre con Pietra senza titolo, mi metto a srotolare, nei pressi della cava abbandonata di marmo verde di Prato, sopra le rocce e le radici, un lungo foglio di carta lucida e con l’inchiostro ci dipingo, quasi montandoci sopra. Quelle sono zone soggette spesso a giornate di gran vento e quelli sono i momenti migliori. Il foglio non sta mai fermo, certe volte non rimane nemmeno niente dell’opera perché finisce distrutta, di solito la carta non aderisce al mio intervento, quanto invece, spiegazzata e incrinata, inizia a somigliare a tutto ciò che le è intorno, sotto e sopra, diviene il suolo che la sostiene, diviene il paesaggio, il frammento, il mondo. Mi pare che l’atto di dipingere trasporti l’opera in balia della natura e, in balia di questo ritmo, è come se l’opera si generasse entrando, a sua volta, in conflitto con i miei gesti che, solo certe volte, in alcuni brevi momenti, come attese necessarie ad entrambi, a me e a lei, pare benevolmente accogliere. Fino al momento di una resa reciproca, quella della conservazione e della conversione, dell’arrotolamento, del ripiegamento dell’opera su sé stessa, di una genesi al contrario. L’opera non ha altro modo di rivelarsi, la porto via così, sottobraccio, con la pelle rovesciata, percependola finita e sfinita. Ma tutto questo è solo una delle in-finite possibilità, solo una delle in-finite derive, solo uno degli in-finiti approdi.

Massimiliano Turco, Divenire, 2016
Che ruolo ha per te la rovina in una città come Roma, dove archeologia, mito e invenzione si intrecciano?
Se ha un ruolo preciso non credo di poterlo sapere. Non lo so, mi aiuta molto un ricordo che ho della periferia di Roma, perché un po’, da bambino, l’ho vissuta. Quando passavamo da un certo quartiere, erano gli anni Ottanta, con la macchina di mio padre, giravamo intorno a un centro commerciale bianco che mi pareva nuovissimo e vecchio al tempo stesso. E proprio lì vicino, quasi attaccato ai muri di questo edificio, emergeva, da una collinetta d’erba lunghissima che prendeva la scena, un rudere color del tufo, come un grande tronco d’albero senza rami. Questa cosa, che guardavo ogni volta, mi pareva degna della mia attenzione, mi incuriosiva e mi convinsi fosse importante. Mi sembrava che quella periferia moderna, intorno, non riuscisse a vivere il presente quanto già, invece, lo vivesse quel rudere. Tutto ciò si rafforzava nelle relazioni che questo mio pensiero creava. Naturalmente da bambino non potevo che esprimermi dicendo che quel che stavo vedendo, ma di cui non sapevo nulla, fosse per me bello. Il fascino e l’ansia, che si portava dietro quella visione, diventavano più forti quanto più mi rendevo conto, guardandomi intorno, che essa pareva esser bella solo per me. Probabilmente, dopo, vedendo a Roma il Colosseo per la prima volta, devo aver avuto la sensazione di conoscerlo già, di averlo visto prima, in periferia. Credo abbia origine pure da questo sentimento un senso di responsabilità dell’artista.
Stando alle tue parole, «le opere sono strutture armature su cui tempo e spazio sedimentano». Gesto, segno, memoria, tempo. Come si sviluppano queste tematiche nella tua ricerca?
Più che tematiche sono valori psicologici che alimentano la ricerca stessa. La natura del mio lavoro è poco incline a processi razionali. Mi ricordo, semmai, di certe sensazioni infantili e, forse, anche adolescenziali che somigliano a quello stato interiore attuale che è ora una spinta vitale per il mio lavoro. Sento, nel lavorìo, di evidenziare qualcosa che mi attrae, che inseguo e che pure mi insegue, un certo ritmo ansioso e infinito che abita soprattutto certe cose ferme. Disegnando con marmo e inchiostro, o disegnando su carta e roccia in Divenire, mi limito a registrare i respiri di una certa ombra vitale. Attraverso la ripetizione insistente di una sintesi pittorica e psicologica, quale è il segno, mi pare, pure nello sfinimento, di avvertire fisicamente una corrispondenza insopportabile e, al tempo, attrattiva tra l’energia dei segni e la carne del corpo. Ho impiegato qualche mese a generare Rizoma, come pure Flusso, in un processo che spinge l’occhio, e non solo, a visualizzare il tempo nell’evidenza di uno spazio e ad evidenziare lo spazio attraverso la visualizzazione di un tempo. Così, sulla lastra, il tempo del primo segno tracciato corrisponde col tempo dell’ultimo. È un tempo che, forse, somiglia a quello dei sogni, in cui si perdono e si ritrovano i riferimenti. Il passaggio dei segni sul marmo determina un forte senso di irriconoscibilità, di perdita. Mi pare che il mio lavoro abiti uno stato che non appartiene a nessuna delle parti che lo compongono ma, al tempo stesso, continui a somigliare a tutte quelle parti. In certi momenti particolari, nella ripetizione, nel ritmo, il movimento del gesto di segnare appare fermo, come se nel processo, ad imporsi, fosse un evidente senso di sospensione.
